Viale dei Giganti: la vita del più grande serial killer della storia
“Pa’, ho una buona notizia e una cattiva. Quella buona è che ho ammazzato la nonna. Quella cattiva è che ho ammazzato anche il nonno. L’ho fatto per risparmiargli il dolore di vedere la nonna morta”

Edmund Kemper ha sessantacinque anni. È alto due metri e sei centimetri, pesa oltre centotrenta chili e ha ucciso parecchie persone. Dieci, per la precisione. Tra queste i suoi nonni paterni, quando aveva quindici anni; sua madre, quando di anni ne aveva ventuno. Nel mezzo, fra queste due date, ha ammazzato almeno sei autostoppiste, caricate nei pressi dell’università di Santa Cruz tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70.
Di giorno Ed vendeva motociclette, tanto da guadagnarsi diverse volte il premio come “miglior impiegato del mese”. La sera, invece, andava al campus (dove lavorava sua madre, segretaria del direttore della facoltà di psicologia) per offrire un passaggio alle studentesse che rientravano dai corsi. Ne ha caricate decine, forse centinaia, ma ne ha uccise - almeno secondo quanto dichiarato alla polizia - “solo” sei.
Ha riservato loro un trattamento speciale: prima le ha fatte passare a miglior vita, strangolandole, pugnalandole o sparando loro con pistole di grosso calibro; poi, da morte, le ha smembrate, sezionate, decapitate, trasportando i loro resti in casa della madre, dove ha abusato sessualmente dei cadaveri. Preferibilmente delle teste mozzate. Per lui, era l’unico modo di eccitarsi.
Ha fatto lo stesso con sua madre, la sua penultima vittima (l’ultima è stata la migliore amica di lei, Sally). L’ha uccisa a martellate. Tre, per la precisione, date sul cranio di una donna addormentata con tutta la forza di un uomo di centotrenta chili. Poi l’ha decapitata, ha violentato il cadavere e, una volta esaurito il desiderio, ha portato la testa mozzata in salotto, l’ha messa in bella mostra sul caminetto e l’ha usata come tiro a segno con delle freccette da bar.
È così che la polizia ha ritrovato Clarnell Strandberg, su suggerimento di suo figlio. Attorcigliati al tritarifiuti, il coroner ha anche identificato i resti delle corde vocali della donna. “Mi sembrava appropriato”, disse in proposito Kenner, “visto che non aveva fatto altro che urlare e inveire contro di me per anni”.
Era il 1973.
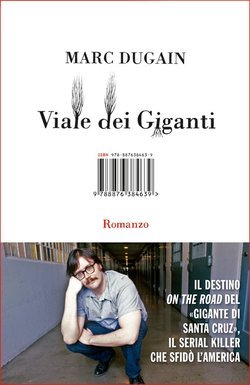
Così Kemper pianta due pallottole di fucile in testa a sua nonna “per vedere che effetto fa” (è quanto disse Kenner ai poliziotti quando si costituì la prima volta, nel ’64). Ma qualche pagina dopo quel raptus diventa, più pietosamente, “un bisogno, una questione di sopravvivenza”. “O lei o me. Se non l’avessi fatto, mi sarei sicuramente ucciso nei giorni successivi. Ho barattato la sua vita con la mia”, dice Kemper allo psicologo dell’ospedale psichiatrico dov’era rinchiuso, convincendolo della sua “buona fede” di ragazzo maltrattato, ed evitando così di apparire per quello che era: un gigante di sadismo.
Del resto, Dugain lo ripete più volte durante il romanzo, Kenner/Kemper ha un quoziente intellettivo superiore a quello di Einstein. Un'intelligenza che lo spinge, anche involontariamente, a manipolare chi gli sta intorno: “Il giorno in cui sono stato esaminato dalla commissione psichiatrica che mi ha riabilitato avevo due teste nel bagagliaio della macchina”. È in questo aspetto che risiede il grosso limite del romanzo. Non convince la giustificazione di Kemper secondo cui “alle volte non abbiamo scelta, dobbiamo uccidere per non morire”. E l’autore probabilmente se ne rende conto, tant’è che dissemina lungo tutto il testo gli indizi di una contraddizione evidente: da un lato il voler mostrare l’aspetto umano (“troppo umano”) di Kemper, bambino vittima del divorzio dei genitori prima, ragazzino umiliato da una madre tirannica poi; costretto all’omicidio “perché non aveva scelta”, perché in una famiglia del genere l’unica scappatoia è dedicarsi furiosamente all’atto di uccidere.
Dall’altro, Dugain sceglie di dare la voce al mostro per fargli esporre le sue ragioni, la sua logica perversa fatta passare per perfetta coerenza. Chi può credere a un pluriomicida pronto a invocare “l’incapacità di intendere e di volere per l’umanità intera”, ma non per lui? Un uomo capace di gridare “bisogna che questa società capisca, una volta per tutte, che non sono nato per uccidere”, prima di fare a pezzi altre otto persone? Lo stesso uomo che ama guardare negli occhi delle sue vittime, per scorgere “quella forma di nudità assoluta che è la morte”, e che si eccita solo se la donna con cui ha a che fare ha almeno la testa e le mani mozzate.
“Ho iniziato a scrivere le mie memorie, ma so che mancheranno sempre di quello che, camuffato o meno, è il sale stesso di un libro: l’empatia”. Viale dei Giganti risente della stessa mancanza. È un libro crudele come il suo protagonista: sensibile nei confronti di uno dei serial killer più efferati della storia, quasi del tutto indifferente al destino delle sue numerose vittime.
Affetto da una variante della sindrome di Stoccolma, Dugain ha scritto un romanzo freddo come un tavolo da obitorio che - forse proprio per quella stessa freddezza - certi lettori apprezzeranno.
Lasciare un commento
Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina
Se non sei registrato puoi farlo qui
Sostieni la Fondazione AgoraVox







