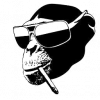Come siamo arrivati al referendum in Crimea (partendo da lontano)
Long read per il weekend, in modo da arrivare preparati a domenica, giorno in cui si terrà il referendum che sancirà l'indipendenza della Crimea dall'Ucraina. L’obiettivo di questo pezzo è offrire un punto di vista più lucido degli eventi in corso in Ucraina ed in Crimea, attraverso un’analisi storiografica che parte dalla Rivoluzione Francese per arrivare ai giorni nostri, dove i paesi occidentali hanno dichiarato illegale il referendum indetto dal Governo autonomo di Crimea. Nonostante questa presa di posizione, nulla potrà impedire alla Crimea di decidere del proprio destino.
Il 16 marzo si terrà un referendum che con molta probabilità sancirà l’annessione della Repubblica Autonoma di Crimea alla Federazione Russa. Fin dalla Rivoluzione bolscevica, la Crimea è stata abitata prevalentemente da russi. In precedenza la maggioranza etnica era composta da tatari, di origine turco-mongola. Oggi i tatari sono una minoranza, a causa della pulizia etnica attuata da Stalin nel 1937 e nel 1944 (quest’ultima data è tragica per il popolo tataro, ed è conosciuta con il nome di Surgunlik). Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1954, Nikita Chruščëv - che era ucraino - cedette in “regalo” la penisola di Crimea alla Repubblica Socialista d’Ucraina, peraltro violando la Costituzione russa, e senza aver chiesto nessun tipo di parere popolare. Ai discendenti dei tatari sopravvissuti alla pulizia etnica staliniana e alle deportazioni, è stato permesso di rientrare in Crimea solo nel 1989. Oggi i tatari sono circa il 15% della popolazione crimeana, mentre il 60% è di etnia russa e il restante di etnia ucraina. Bisogna comunque evidenziare come quasi il 90% della popolazione parli il russo come lingua corrente.
Felix Stanevskiy, già ambasciatore russo in Italia, ha spiegato che in Crimea esiste una vera e propria frattura psicologica, causata dal “regalo” di Chruščëv del 1954. Secondo l’autorevole parere di Yaroslav Pylynskyi, direttore della divisione Kennan Institute al Wilson Center, questo “regalo” fu in realtà giustificato dalla volontà dell’Urss di scaricare i costi di ricostruzione post-bellica della Crimea - una delle zone più povere della regione - sulla Repubblica Socialista d’Ucraina. Il passaggio all’Ucraina non ha regalato sviluppo economico, e tutt’oggi il Pil pro capite della Crimea è due terzi più basso della media ucraina e l’80% più basso della media russa. Quando si votò nel 1991 sull’indipendenza dell’Ucraina dall’Urss, la Crimea fu la regione dove l’entusiasmo per il distacco dalla casa madre fu molto più mitigato che altrove. Poco più del 50% dei votanti scelse l’indipendenza dalla Russia. Questo dato va contestualizzato: era il periodo conclusivo della Guerra Fredda, che vedeva l’Unione Sovietica sconfitta politicamente e sull’orlo del baratro a livello economico. Di conseguenza la Russia era priva di appeal geopolitico, cosa che non si può più dire oggi, epoca della politica muscolare di Putin.
I paesi occidentali, hanno dichiarato “illegale” il referendum del 16 marzo. In questi casi, dove vengono annunciati plebisciti, dichiarare l’illegalità di un voto referendario è irrisorio. Va da sé che un referendum di questo tipo, tenuto a queste condizioni, sicuramente non sarà libero da interferenze russe: al netto di tutto, risulta di certo politicamente poco credibile un referendum organizzato da un governo autonomo sostenuto da forze di occupazione straniera. La Crimea oggi è infatti militarmente occupata da forze militari russe, sebbene in via “non ufficiale”. Ciò però, ai fini della risoluzione del problema identitario ed etnico, di fatto ha poca rilevanza, specialmente per quel che riguarda la legittimità o la legalità del referendum. Per fare un esempio tra i tanti possibili, basti pensare che la Polonia - una delle nazioni più risolute nel sostegno ucraino in posizione anti-russa, e quindi del tutto contraria al referendum in Crimea - fu il primo Stato slavo a riconoscere nel 2008 l’indipendenza del Kosovo dalla Serbia, anch’esso rivendicato dalla popolazione kosovara attraverso un referendum - allora non riconosciuto a livello internazionale - tenutosi anni prima, che vide l’80% di affluenza e il 98% di voti favorevoli all’indipendenza. Tutt’oggi in Kosovo vige “legalmente” la Risoluzione Onu 1244, che stabilisce la sovranità serba sul territorio kosovaro. Gli Stati Uniti, e molti paesi europei, riconoscono invece la sovranità kosovara. Cos’è quindi legittimo? Cos’è quindi legale?
D’altronde è lo stesso Onu che garantisce, attraverso la Carta delle Nazioni Unite all’art.1, par.2, il diritto dei popoli all’autodeterminazione in quanto ius cogens, cioè diritto supremo ed inderogabile. Questo principio venne assunto ed enunciato per la prima volta nel Trattato di Versailles, ma fin da subito si dimostrò un principio arbitrariamente interpretabile (come sovente accade più in generale con tutto il diritto internazionale, che di fatto non esiste, non esistendo un’autorità unica che lo faccia rispettare). In più la Convenzione di Montevideo del 1936 stabilisce che una qualsiasi etnia che seceda da un’entità sovrana, per fare politica estera debba farsi Stato-nazione, ed è quindi naturale che l’obiettivo ultimo di molti popoli – di qualsiasi latitudine - sia creare un proprio Stato autonomo (si pensi alla Scozia, che farà a breve un referendum sull’indipendenza, oppure ai problemi tribali in Libia). L’autodeterminazione dei popoli era un principio utilizzato anche prima dell’inserimento di quest’ultimo nella cornice giuridica del Trattato di Versailles; di plebisciti e referendum rispondenti a questo principio furono tenuti anche precedentemente al 1919. Va da sé quindi che le considerazioni giuridiche quando prese da sole hanno poco valore fattuale se si parla della volontà di un popolo di scegliere sulla propria sovranità. Di solito gli Stati esistenti sono riluttanti nel riconoscere nuove sovranità, poiché questo riconoscimento potrebbe innescare spinte secessioniste all’interno degli stessi Stati, che vedrebbero andare in frantumi lo status quo, tranne nei casi - come la Russia con la Crimea - in cui vi sia un interessamento di parte, diretto o indiretto, sulla faccenda. Uno stesso Stato, per motivi di politica interna, potrebbe appoggiare l’autodeterminazione di un popolo, e al contempo rifiutarla per un altro popolo. Per rimanere nella sfera di influenza russa, basti pensare al diverso atteggiamento che Mosca ha tenuto nei confronti della Cecenia, dell’Ossezia del Sud (teoricamente a sovranità georgiana) e della Crimea. Il principio dell’autodeterminazione è subordinato agli interessi degli Stati, ed è meglio farsene una ragione. Più in generale le questioni di principio, di legalità e di legittimità, in casi di questo tipo andrebbero relativizzate nel contesto, in modo da poter affrontare i problemi in maniera meno ideologica e più pratica, senza dimenticare che in ultima istanza ciò che vale non è il “diritto”, ma la logica di potenza, le alleanze storiche, le identità, l’inimicizia e la sovranità, intesa come la intendeva Carl Schmitt: sovrano è chi decide nello “stato d’eccezione”.
Matt Qvortrup, dell’Università di Cranfield, è ritenuto uno dei massimi esperti mondiali in tema di referendum etnici sull’autodeterminazione. In un commento su un giornale scozzese, Qvortrup afferma che in piccole enclavi etniche di tendenza democratica, i politici tentino spesso di perseguire scelte che siano popolari, in modo da massimizzare il sostegno al proprio partito. In questi casi, secondo lo studioso, si ricorre al referendum per l’autodeterminazione se vengono soddisfatte due condizioni: quando i leader si sentono minacciati dall’esterno, e quando percepiscono che la maggioranza degli elettori supporterebbe la loro linea politica. In Crimea entrambe le condizioni sono soddisfatte. Se i leader (e la popolazione) di Crimea non si fossero sentiti in qualche modo minacciati - nella propria identità e nella propria autonomia - non si sarebbe arrivati a questo punto. Anche la percezione (giusta o sbagliata che sia) è un fattore spesso determinante. A ciò va aggiunto l’innegabile interessamento russo nel riprendere possesso di un territorio che “storicamente” ed etnicamente gli è appartenuto fin dall’inizio del ‘900. La questione è quindi complicata, ma non nuova. La storia delle Nazioni è infatti costellata di referendum di tipo etnico-nazionali, più o meno genuini, più o meno democratici (e va sottolineato come “referendum” ≠ “democrazia”).
La storia di questi plebisciti è stata riassunta da Qvortrup in un articolo del 2012 apparso sulla rivista accademica “Nationalism and Ethnic Politics” (“The History of Ethno-National Referendums” 18:129-150, Taylor & Francis Group), e può essere utile ripercorrerla per provare a dare una catalogazione delle diverse fattispecie di referendum etnico-nazionali messi in pratica nel passato. Il periodo preso in analisi è quello che parte dalla Rivoluzione Francese - periodo in cui nacque il termine “auto-determinazione” - fino ad arrivare ai giorni nostri, e fa capire come possano essere diverse tra loro le consultazioni referendarie, sia nello svolgimento che negli obiettivi. I referendum possono ad esempio essere un modo per risolvere pacificamente un negoziato e sigillarlo nella sua legittimità, come è accaduto in Irlanda del Nord nel 1998, oppure in Burundi nel 2005, dove un referendum approvò la soluzione negoziata tra le tribù Hatu e Tutsi. Un referendum a caratura etnico-nazionale dovrebbe essere chiamato solo a seguito di negoziati, quando si è già vicini ad un compromesso. Diversamente potrebbe accadere che un referendum chiamato unilateralmente - specie riguardante questioni notoriamente delicate come quelle territoriali ed etniche - produca tensioni, se non una vera e propria guerra civile. Brendam O’Leary (dell’Università della Pennsylvania) e John McGerry (della Queen’s University dell’Ontario), hanno sviluppato una tassonomia che seziona le tipologie di referendum etnici.
La prima differenziazione che va fatta riguarda i referendum che provano a gestire le diversità etniche (“difference managing policies”) e quelli che invece puntano ad eliminarle attraverso l’omogenizzazione (“difference eliminating policies”). Un esempio del primo tipo può essere trovato nel referendum che sancì la devolution in Scozia, Galles e Irlanda del Nord nel 1997-1998, mentre un esempio del secondo si può trovare nel plebiscito (“Anschluss”) tenuto nel 1938 in Austria, e che decretò l’annessione di quest’ultima al Reich nazista. I due modelli sopra esposti si dividono ulteriormente in altre due categorie: i referendum secessionisti - che sanciscono la separazione di un territorio e della sua popolazione da un’entità statuale sovrana più ampia - e quelli di “ridimensionamento” (detti di right-sizing ) - che risolvono problemi riguardanti confini e suddivisioni territoriali tra due entità statuali confinanti; se la Crimea in seguito al referendum del 16 marzo dovesse passare sotto sovranità russa, sarebbe un caso di questo tipo, anche se alcuni aspetti potrebbero far suggerire un’altra similitudine con la situazione dei territori dei sudeti annessi alla Germania nel 1938 (in quel caso però non vi fu nessun tipo di referendum). Un’ulteriore classificazione andrebbe fatta per il grado di democraticità non solo del referendum, ma anche della società in cui prende forma, con tutte le difficoltà di analisi del caso.
Sebbene sia possibile rintracciare plebisciti di tipo etnico anche in alcuni periodi della storia antica, secondo uno studioso francese di inizio ‘900, Eugène Solière, la prima volta che nella storia si registrò un plebiscito - definito come un voto in cui a (quasi) tutti gli adulti fu chiesto di scegliere tra proposte differenti riguardanti questioni etnico-nazionali-territoriali - fu nel XIII secolo, quando Lione, che allora faceva parte del Sacro Romano Impero, volendo fuggire dal potere della Chiesa, invocò la protezione del Re di Francia. Al netto di ciò, Qvortrup sostiene sia più indicato far coincidere la nascita dei referendum nazionali con l’emersione del fenomeno sociale del nazionalismo laico, e cioè al periodo che seguì la Rivoluzione Francese. Il nazionalismo è per sua natura condizionato dalle questioni etniche e culturali, e risulta impossibile separare la questione nazionale da quella etnica (si veda al riguardo il saggio “Le origini etniche delle Nazioni” di Anthony D. Smith). Il grado di intensità e di attrito tra componenti etniche diverse all’interno di uno stesso Stato può essere mitigato dalla presenza di istituzioni politiche più aperte (e di conseguenza più democratiche), da forme di autonomia più marcate, e da un’assenza di inimicizia storica tra le parti. Quando queste condizioni non sussistono, il ricorso alle armi, alla violenza ed alla sopraffazione di un gruppo da parte di un altro, diventa più probabile se non ineluttabile.
Dal 1791 ad oggi, da quando cioè Avignone decise di annettersi per plebiscito alla Francia contro il volere papale, si sono tenuti centinaia di referendum che hanno modificato confini nazionali, composizioni etnico-territoriali, e divisioni del potere tra diversi gruppi etnici stanziati sullo stesso territorio. In seguito alla disfatta definitiva di Napoleone, l’istituto del referendum e del plebiscito cadde in disuso. Le cose cambiarono a partire dalle rivoluzioni del 1848. Addirittura Luigi Napoleone (Napoleone III, dal 1852), per legittimare il colpo di Stato da lui guidato, fece ricorso al plebiscito (che fu tutt’altro che democratico, visto che sulle schede elettorali c’era prestampato solo il “sì”). In Italia i movimenti irrendentisti del 1860 fecero ampio uso dello strumento politico referendario per risolvere le tensioni etnico-territoriali. La situazione politica della penisola e del continente europeo, rese possibile in quel periodo immaginare una nazione italiana unitaria. Il processo di state-building portato avanti dalle élite politiche ed intellettuali del Regno di Sardegna - su tutti da Camillo Benso Conte di Cavour - ebbe un discreto successo, ed evitò probabilmente alcuni conflitti. Scrive infatti Philip Goodhart nel suo saggio “Referendums and Separatism”, che fu proprio nell’Italia risorgimentale che i plebisciti ebbero il loro periodo d’oro, e che anzi, l’Italia moderna è stata letteralmente costruita a colpi di referendum. Nel 1848 in Lombardia più di mezzo milione di elettori (sui 660 mila aventi diritto) votarono per l’annessione al Regno di Sardegna. Nel 1870 circa 70 mila romani votarono per l’unione con l’Italia. Tra le due date si tennero referendum in Toscana, in Emilia, in Sicilia, a Napoli, in Umbria e in Veneto. Anche in questo caso bisogna separare l’istituto del referendum dall’idea di “democrazia” vera e propria. Nel Regno delle Due Sicilie e nel Veneto, ad esempio, i “sì” ed i “no” venivano votati in urne differenti, sotto l’occhio vigile dei soldati del Regno di Sardegna.
Referendum etnico-nazionali sono stati spesso chiamati per convenienza da politici che già erano al governo. In questo senso si può citare l’uso che ne fecero i popoli anglosassoni. L’Inghilterra, che nel 1800 deteneva il più grande e potente impero esistente, utilizzò lo strumento referendario specialmente per obiettivi di omogeneizzazione e per calmierare le tensioni in Canada ed in Australia. Allo stesso tempo però i sapienti politici inglesi ebbero modo di utilizzare il plebiscito per motivi di tattica internazionale, come è avvenuto in Moldavia: nell'agosto del 1857, la Francia, il Piemonte e l'Inghilterra, riuscirono ad ottenere l'annullamento delle elezioni in Valacchia ed in Moldavia - che avevano riportato sotto il controllo ottomano quei territori dopo la sconfitta russa nella Guerra di Crimea -, facendo convocare nuove assemblee dove il fronte degli indipendentisti rumeni riuscì ad ottenere, non senza bizzarre manovre diplomatiche, una sostanziale indipendenza sotto il patrocinio dei vincitori della precedente guerra svoltasi nella penisola del Mar Nero.
La maggioranza dei referendum etnico-nazionali tenuti dalla Rivoluzione Francese fino alla fine della Prima Guerra Mondiale sono inscrivibili nella categoria “right-sizing”, seguiti da quelli di “difference-managing” e dai referendum secessionisti. Si può notare come in questo periodo storico non siano mai stati chiamati referendum con l’obiettivo dichiarato di eliminare le diversità etniche, cosa che invece accadde spesso nell’epoca dei totalitarismi specialmente nelle aree germanofone. Hitler infatti abusò dei plebisciti per eliminare le differenze etniche e creare il proprio Reich “puramente” tedesco. Ciò che stupisce è la relativa genuinità di quei plebisciti, tanto che un osservatore americano dell’epoca scrisse “anche dopo la messa in atto di pressioni intangibili ufficiali, di cui indubbiamente bisogna tener conto [...] le intimidazioni ai seggi sono state probabilmente molto poche, e il risultato elettorale rimane incredibile”. Ciò dovrebbe mettere in guardia dal pensare che ogni voto elettorale, ogni “bagno di democrazia” sia tutto sommato qualcosa di auspicabile ad ogni costo.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale circa una cinquantina di referendum e plebisciti etnici e nazionali hanno interessato tutte quelle aree del mondo che erano soggette a domini coloniali. La de-colonizzazione, specialmente francese, favorì lo strumento referendario. Dalla fine degli anni ‘60 in poi, fino ad arrivare alla caduta del Muro di Berlino, lo strumento del referendum ricadde in disuso, a causa delle costrizioni sistemiche di un sistema internazionale schiacciato sulla bipolarità e sul confronto tra Usa e Urss. Fu infatti dopo la caduta del Muro di Berlino che si tornò ad utilizzare il referendum per dirimere questioni territoriali ed etniche. Dal 1989 al 1993 si tennero ben 34 referendum di questo tipo. Siamo nell’epoca della frammentazione, dove il sistema internazionale vede un’incredibile impennata della natalità statuale. La fine del comunismo sovietico ha sprigionato energie e spinte motivazionali etniche che fino a quel momento erano anestetizzate dalla contingenza della Guerra Fredda. Le identità etniche e nazionali sono tornate ad avere quell’importanza che nei precedenti 50 anni era stata involontariamente sottodimensionata. Il sistema internazionale è passato dai 50 Stati nel 1945, agli 83 del 1959, ai 149 del 1979, per arrivare agli oltre 190 nel 2006. Secondo Wikipedia oggi gli Stati esistenti al mondo sono circa 200, ma il numero è destinato a salire nei prossimi anni. La globalizzazione, inoltre, ha offerto una vetrina fenomenale alle secessioni di successo, ed ha agevolato il “contagio” identitario e, tornando alla Crimea dei nostri giorni, esiste un concreto ed ulteriore rischio di “effetto domino”.
A pochi kilometri dalla penisola di Crimea, sul confine tra Ucraina e Moldavia, esiste la Transnistria, un territorio a sovranità moldava, che de facto è indipendente. Dal censimento del 2004 risulta che la popolazione sia così ripartita: 31,9% moldavi, 30,3% russi e 28,8% ucraini. La Transnistria è filo-russa, e fa parte - con l’Ossezia del Sud e l’Abkhazia - della “Comunità per la democrazia e i diritti dei Popoli”. Questa divisione etnica è figlia di un passato storico che ha visto la regione passare di mano in mano a diverse sovranità, tra cui rumena, russa ed ucraina (la ricca città di Odessa è oggi in Ucraina). Qui l’Urss costruì industrie e favorì lo sviluppo, in modo da incentivare cittadini russi a trasferirvisi. Nel 1990, la Regione della Transnistria rappresentava il 40% del Pil moldavo e produceva il 90% dell'energia elettrica dell'intera Repubblica di Moldavia. Dopo la fine dell’Urss il governo Moldavo attuò diverse politiche di marginalizzazione delle minoranze. I moldavi sono etnicamente e linguisticamente affini ai rumeni, e non è segreta la volontà delle élite moldave di unirsi politicamente alla Romania. Nel 1990, a seguito di queste politiche nazionaliste, in Transnistria si tenne un referendum per staccarsi dalla Moldavia e il 90% dei votanti scelse l’indipendenza. Nel 1992 si giunse anche allo scontro armato tra la Moldavia (armata e supportata dalla Romania) e la Transnistria (armata e supportata dalla Russia e dall’Ucraina). La Russia tutt’oggi supporta l’indipendenza de facto della regione, e non è ben chiaro quali effetti potrebbe avere la situazione ucraina e di Crimea sulle dinamiche etniche e territoriali della Moldavia. Nel 2005 il Governo ucraino (filo-occidentale) guidato da Viktor Juščenko tentò una mediazione, che però fallì, anche a causa del mancato supporto russo all’intesa. L’Ucraina allora si avvicinò alle posizioni moldave, spingendo gli abitanti della Transnistria (ucraini e russi) verso la Russia, che tutt’oggi stanzia dei battaglioni (circa 1500 uomini) sul suo territorio.
Per capire di cosa abbiamo parlato fino ad ora, e quali sono i rischi che si corrono nella regione, si dia uno sguardo alla cartina dell’Ucraina qui sotto, divisa per popolazione linguistica in base al censimento del 2001 (in blu le aree a maggioranza etnico-linguistica ucraina, in rosso quelle a maggioranza russa, in verde i rumeni\moldavi, in verde acqua i tatari, in arancione gli ungheresi, in viola i bulgari, eccetera).
Appare evidente come sia stato quasi inevitabile l’allontanamento della Crimea dal nuovo Governo anti-russo ucraino, e come siano state poco lungimiranti e poco razionali le scelte prese nell’ultimo mese dell’Occidente e dei leader nazionalisti ucraini. Quella regione multicolore che si vede a sud-ovest è la regione di Odessa, vicino alla Transnistria: è una delle regioni più ricche dell’Ucraina, fortemente dipendente dal mercato russo, e con una popolazione variegata ma generalmente filo-russa, come sono filo-russi anche molti ucraini etnici che vivono nelle zone orientali del Paese, e che vedono nella Russia il fraterno compagno di viaggio della nazione ucraina.
Martedì 11 marzo il Parlamento di Crimea ha votato per l’indipendenza con una schiacciante maggioranza di 78 voti su 81. Il referendum del 16 marzo sarà quindi un plebiscito che confermerà e metterà il sigillo sulla secessione dall’Ucraina e sull’annessione - in essere di Repubblica Autonoma di Crimea - alla Federazione Russa. La sapienza degli amministratori crimeani filo-russi ha suggerito loro di offrire ai tatari posti di rilievo nel nuovo esecutivo (vice-premier, due ministeri, e alcuni vice-ministri tra cui quelli dell’interno e della difesa), e di rendere la lingua tatara lingua ufficiale. Il Parlamento della Crimea ha inoltre deciso il ripristino dei nomi originali tatari di alcuni toponimi geografici, come montagne e fiumi, che furono modificati al momento della pulizia etnica di epoca staliniana. Queste operazioni sono chiaramente opportunistiche, ma portebbero rendere meno traumatica e più pacifica la soluzione indipendentista, vista la storica avversità - giustificata, spiega Marc Champion sul Japan Times - che il popolo tataro ha nei confronti dei russi (tanto che un centinaio di tatari ora si trovano in Siria per combattere Assad, che è alleato della Russia).
La complessità della situazione consiglierebbe quindi una certa cautela. Cautela in ogni direzione; bisognerebbe avere ben presente il significato che può assumere un confronto etnico nel mondo contemporaneo, cercando di comprendere quanto sia importante, oggi più di ieri, il concetto di “identità” e di “cultura”, non dimenticando le necessità strategiche e geopolitiche di tutti gli attori coinvolti, lasciando momentaneamente da parte le questioni di “principio”. Una delle soluzioni più ponderate l’ha proposta Henry Kissinger, in un editoriale sul Washington Post. Lo statista e diplomatico americano ha spiegato che porre la questione dell’Ucraina come se fosse uno scontro tra “Occidente” e la “Russia” sia pericoloso specialmente per il popolo ucraino, popolo che potrebbe in realtà fare da “ponte” tra le due civiltà: “Washington - scrive Kissinger - dovrebbe adoperarsi per superare la spaccatura tra le forze politiche belligeranti in Ucraina invece di demonizzarne una di loro”. Uno dei difetti che Kissinger trova all’origine dell’improvvisata gestione occidentale degli eventi in Ucraina è la scarsa conoscenza della storia e della psicologia russa. Cercare di portare un paese come l’Ucraina nella Nato sarebbe un grave errore, e potrebbe causare una guerra civile nel paese. Se non peggio. L’Occidente dovrebbe quindi accettare le considerazioni di carattere etnico-nazionale che hanno favorito l’emergere dell’attuale situazione geopolitica della Crimea, accettare i risultati del referendum, e convincere i nazionalisti ucraini che questa è la soluzione migliore per dipanare le tensioni. Allo stesso tempo bisognerà ricevere assicurazioni ufficiali da parte di Mosca riguardo alla propria volontà di non andare oltre con le mire espansionistiche. Non sarà infatti raccontando al mondo che quel referendum “è illegale” che si risolveranno le tensioni.
Mai nella storia è successo che una dichiarazione di questo tipo - morale, legalitaria, giuridica - sia andata a ribaltare un risultato plebiscitario, perché come ha scritto Oswald Spengler nella gigante opera de Il Tramonto dell’Occidente, “una potenza può esser rovesciata solo da un'altra potenza, non da un principio”.
Questo articolo è stato pubblicato quiCommenti all'articolo
Lasciare un commento
Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina
Se non sei registrato puoi farlo qui
Sostieni la Fondazione AgoraVox