La corruzione italiana, i traffici illegali sul territorio palestinese e gli abusi edilizi portoghesi
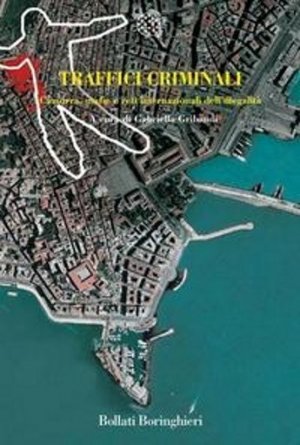
Al convegno organizzato dal Dipartimento e della Facoltà di Sociologia della Federico II di Napoli, in occasione della presentazione del volume “Traffici criminali. Camorra, mafie e reti internazionali dell’illegalità” curato da Gabriella Ribaudi e uscito per Bollati Boringhieri, sono stati presentati tre lavori interessanti: Beatrice Hibou, ricercatrice del CNRS (Centro di studi francese), ha illustrato attraverso delle immagini l’architettura dell’edilizia illegale delle periferie di Lisbona. L’incremento della lottizzazione dei terreni da parte della criminalità, con la vendita di case abusive a tutte le classi sociali, ha spinto alle regolarizzazioni avvenute attraverso leggi successive che hanno confuso i confini tra metodi legali e illegali, fino al punto in cui non è più possibile distinguere le diverse procedure con l’effetto che “illegalitè comme norme” diviene appunto normalità.
L’ultimo lavoro è stato presentato da Stefano Consiglio, presidente del Dipartimento di Sociologia della Federico II, sul fenomeno della corruzione in Italia. Le cifre sono sconcertanti: per la classifica della “corruzione percepita” secondo la Trasparency International Association, l’Italia è al 41esimo posto; per la Corte dei Conti la corruzione costa allo Stato 60 miliardi di euro all’anno (circa il 2% del Pil) e il 48% dei reati legati alla corruzione avvengono in Sicilia, Campania, Puglia e Calabria. Anche se il professor Consiglio lamenta la disponibilità di pochi dati in proposito, il giro d’affari per quanto riguarda un’organizzazione criminale come la ’ndrangheta, con riferimento alle attività corruttive, è stimato a 5.730 milioni di euro annui. “Quello che bisogna fare per studiare approfonditamente l’economia delle organizzazioni criminali è accettare la complessità dei confini sfumati tra legalità e illegalità, allargare la visuale oltre i confini geografici tradizionali, riconoscendo una rete che coinvolge una pluralità di attori come politici, cittadini, amministratori e imprenditori”, spiega il professore.
Lasciare un commento
Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina
Se non sei registrato puoi farlo qui
Sostieni la Fondazione AgoraVox






