Guerra, pace e ingiustizie. L’infelice reputazione dei compromessi
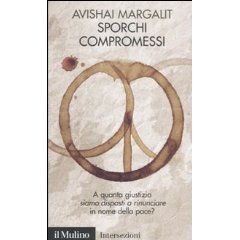
“Sporchi compromessi” è un saggio limpido e profondo, scritto da un filosofo israeliano che conosce molto culture umane, antiche e moderne (Avishai Margalit, www.mulino.it, 2011).
“La minestra migliore è completamente rovinata da un solo scarafaggio”. Paul Rozin (psicologo)
“Io e mio fratello contro mio cugino. Io e mio cugino contro il mondo intero”. Proverbio beduino
“Diffidate dei compromessi sordidi”, ammonì molti anni fa il più grande genio dell’epoca moderna. Albert Einstein ha formulato delle visioni fisiche e filosofiche molto chiare, però i principi generali sono sempre molto difficili da applicare alle innumerevoli situazioni concrete della vita, nelle diverse società umane. In ogni caso, per semplificare le cose, un compromesso politico sordido si può definire così: “Un accordo volto a stabilire, o a mantenere, un regime disumano improntato alla crudeltà e all’umiliazione, cioè un regime che non tratta gli esseri umani da esseri umani”.
In questi casi anche l’indifferenza o il semplice appoggio passivo è da rifiutare. E se gli ideali “possono rivelare qualcosa di importante rispetto a ciò che vorremmo essere, i compromessi ci rivelano chi effettivamente siamo” (p. 11). Purtroppo in filosofia si studiano da vicino e da lontano i desideri emotivi e cognitivi ideali, invece di esaminare la complessità politica quotidiana e le varie “scelte di ripiego. Tuttavia escludere il compromesso dalla teoria morale è come escludere l’attrito dalla fisica, affermando che appartiene all’ingegneria”.
In realtà la vita degli stati è costruita nella maggior parte dei casi su compromessi più o meno sporchi e Margalit fornisce alcuni esempi storici molto significativi: i negoziati arabo-israeliani, il trattato di Monaco, la conferenza di Yalta e l’operazione Keelhaul (la consegna forzata di quasi tutti i prigionieri e dei fuggitivi cosacchi a Stalin alla fine della seconda guerra mondiale).
Per quanto riguarda la macromoralità e le entità politiche, Avishai Margalit ritiene che “la pace può essere giustificata anche quando è ingiusta” (p. 7), e prende in esame i compromessi da cui rifuggire in ogni caso e quelli in cui, in nome di molte vite umane, possiamo rinunciare a un bel po’ di giustizia, in cambio delle sicurezze della pace. I compromessi più “sanguigni” sono quelli che rinunciano ai grandi “sogni” e finiscono per negoziare “solo una gamma di accordi fattibili”. Di conseguenza ogni “politica settaria è l’antitesi dello spirito di compromesso” (p. 21).
In molti casi i compromessi si possono attuare ridefinendo i termini della disputa. Ad esempio la questione della “sovranità sul Monte del Tempio a Gerusalemme” si può limitare alla “disputa sull’utilizzo”. Comunque a mio parere il conflitto tra israeliani e palestinesi non verrà mai risolto finché Gerusalemme non sarà trasformata in una Città-Stato indipendente e a controllo misto, gestita da israeliani, palestinesi e delegati dell’Onu (dovrebbe essere autonoma in base a una risoluzione dell’Onu del 1947). Tel Aviv e Gaza diventerebbero così le capitali dei rispettivi Stati.
In genere “L’arte del compromesso è una grande virtù politica, soprattutto se la si esercita nell’interesse della pace e del bene comune”, e del male minore. Esistono però limiti morali diversi a seconda delle culture religiose, anche se la visione più “economica” e laica si sta diffondendo in molte nazioni. Per fortuna. Infatti gli approcci troppo religiosi impongono tabù assoluti e duraturi.
Alan Page Fiske e Philip Tetlock hanno approfondito i tabù religiosi in questo saggio: “Taboo Trade-offs: Reactions to Transactions that Transgress the Spheres of Justice” (Political Psychology, 1997); si può scaricare facilmente tramite http://ebookbrowse.com. E non bisogna mai dimenticare che la morale religiosa è in molti casi e in buona parte responsabile delle guerre civili più sanguinose. L’unica vera “soluzione pertanto si trova nella ragion di stato, la sola che può assicurare la pace”.
Infine, un esempio di compromesso privato con inestimabili conseguenze planetarie, è stato quello attuato da Robert Oppenheimer, che sviluppò la bomba atomica come contropartita ai notevoli finanziamenti per fare ricerca fisica di base in piena libertà (la fonte è lo scienziato Freeman Dyson, “Lo scienziato come ribelle”, Longanesi, 2009).
Avishai Margalit è professore emerito di Filosofia nell’Università ebraica di Gerusalemme e insegna all’Institute for Advanced Study di Princeton. In Italia ha pubblicato “Occidentalismo. L’Occidente agli occhi dei suoi nemici”, insieme al giornalista Ian Buruma (saggio recensito il 22 settembre 2008 sul neonato Agoravox.it).
Nota – Dal 1945 il numero delle guerre civili è stato circa cinque volte superiore a quello delle guerre tra stati. Una guerra tra stati dura in media tre mesi e una guerra civile dura in media sei anni, con un numero di vittime di quasi cinque volte superiore (J. D. Fearon e D. Latin, “Ethnicity, Insurgency and Civil War”, in “American Political Science Review”, 97, 1, 2003, pp. 57-90).
Lasciare un commento
Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina
Se non sei registrato puoi farlo qui
Sostieni la Fondazione AgoraVox






